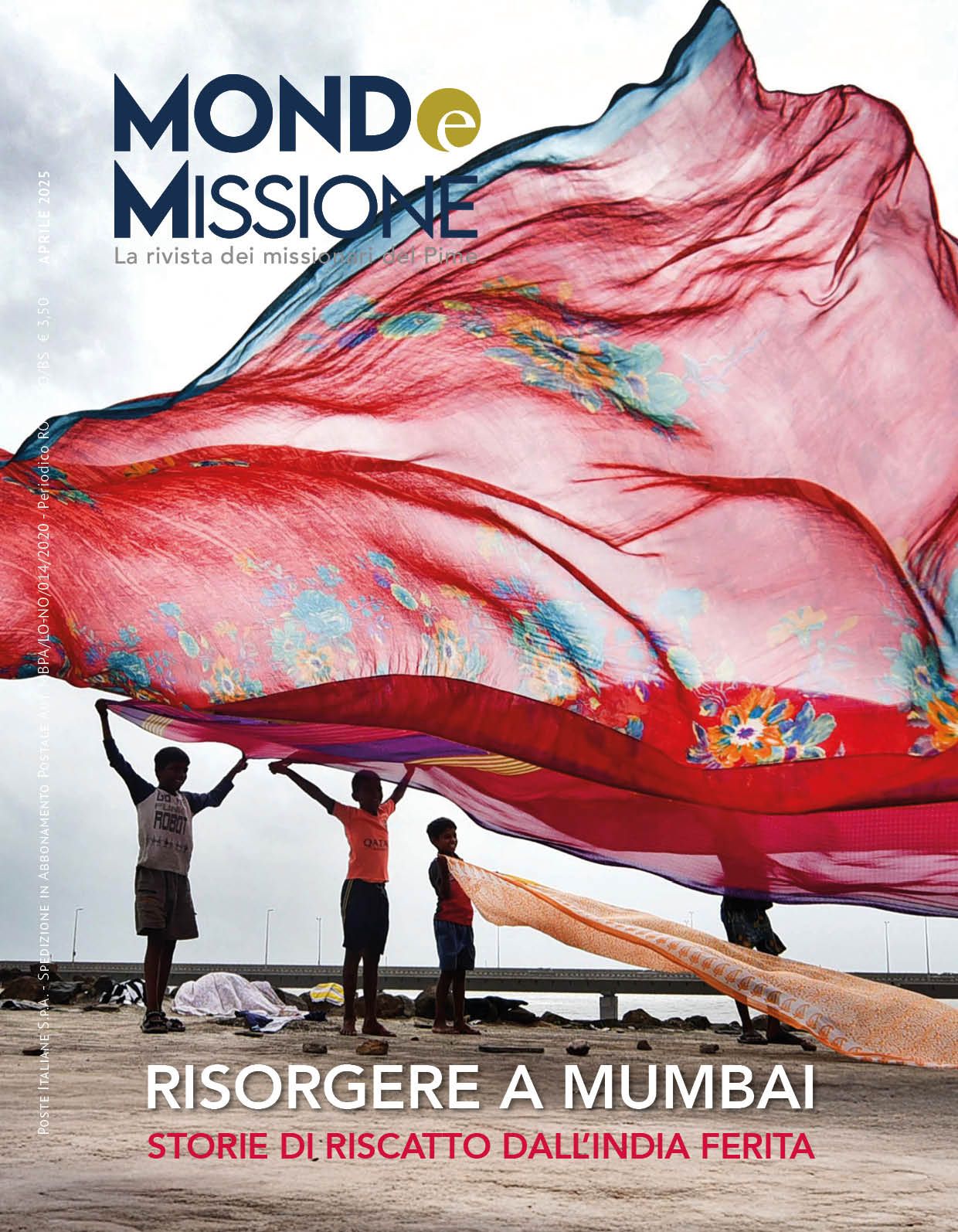Kalash, i misteriosi “nipoti” di Alessandro Magno

In Pakistan, tra i monti dell’Hindu Kush, isolato dal resto del Paese, vive un popolo, che ha mantenuto caratteristiche somatiche e culturali uniche
Da Mingora, capoluogo della regione pakistana dello Swat, servono dodici ore tra bus e fuoristrada attraverso il remoto distretto di Chitral per raggiungere Bumburet, la più grande delle valli abitate dal popolo kalash. Un percorso facilitato negli ultimi anni dal tunnel di Lowari, che si snoda non soltanto attraverso la geografia impervia del Pakistan settentrionale puntando nel cuore dell’imponente catena montuosa dell’Hindu Kush, ma che ripercorre le fasi salienti della sua storia. Tra cui le tante invasioni a partire da quella, nel 323 a. C., di Alessandro Magno, da cui la leggenda vuole che derivino proprio i kalash, una comunità misteriosa conosciuta anche come “l’ultima tribù pagana del Pakistan”.
Siamo in una terra al centro del “grande Gioco” che nel XIX secolo oppose russi e britannici per il controllo di queste regioni di frontiera tra mondo indiano, iranico e centrasiatico. Ma l’area, sebbene uscita dall’isolamento quasi assoluto, conserva caratteristiche uniche. L’ascesa dal fiume Kunar alla valle di Bumburet, la principale delle tre valli kalash (le altre sono quelle di Rumbur e Berir) segna fisicamente “l’alterità” dei luoghi: si percorre tra la roccia viva uno sterrato a picco sulla vallata sottostante prima di incunearsi tra i pendii su cui appaiono la prime abitazioni aggrappate alla montagna, quasi senza distinzione fra l’una e l’altra per meglio gestire lo spazio disponibile, affrontare il rigido clima invernale e utilizzare in modo comunitario le ampie terrazze.
Oggi lo sviluppo e la sicurezza dei kalash sono sotto la tutela internazionale che promuove interventi per la conservazione delle tradizioni e una crescita sostenibile basata sulle risorse locali: tra l’altro si richiede di regolamentare l’immigrazione dal fondovalle, sia economica sia residenziale, ma anche gli afflussi di turisti in occasione dei festival locali che vedono numerosi visitatori e qualche tensione.
In Afghanistan, che da qui dista pochi chilometri, i kalash sono stati convertiti all’islam e la loro terra è oggi la provincia del Nuristan (“Paese della luce”) ma dalla parte pakistana della Linea Durant, stabilita nel 1893 per separare la zona d’influenza britannica da quella russa in regioni contese, la tutela identitaria è stata parte della politica del divide et impera su cui si è basata l’esperienza coloniale. Questo e l’isolamento hanno garantito la persistenza dei caratteri fisici e culturali di una etnia che oggi in Pakistan conta non più di quattromila individui. Una realtà che il governo cerca di preservare nonostante i kalash (i “neri”, per il colore di base degli abiti femminili) mantengano tradizioni incompatibili con l’islam e una fede centrata sul rispetto delle manifestazioni della natura. Il rapporto fra i sessi resta ispirato da cooperazione e da una sostanziale uguaglianza nella gestione delle attività quotidiane. Corale e suggestiva è la partecipazione alle celebrazioni e alle danze che segnano le fasi stagionali dell’agricoltura e della pastorizia.
Una visita al villaggio di Brun consente di accedere al museo dei kalash ed evidenzia le iniziative di sostegno alla popolazione locale. La scuola annessa al museo, pensato come spazio comunitario e non solo per ospitare preziosi oggetti di uso in ambito agricolo, domestico o religioso, segue il curriculum di studi nazionale per studenti delle elementari e delle medie, ma è gestito dalla comunità locale. Qui la divisione fra ragazzi e ragazze è solo segnata dalla divisa, mentre a segnalare la “diversità” dei kalash dai loro vicini sono l’azzurro e il grigio degli occhi e il biondo o castano dei capelli. Una identità che tuttavia va rarefacendosi. Abituata alla convivenza e alla parità fra queste montagne, da tempo la popolazione deve confrontarsi con la pressione che sale dal fondovalle. A partire dalla presenza sempre più consistente di musulmani locali di etnia pashtun o di provenienza ancora più lontana che con una immigrazione anzitutto con finalità economiche veicola influenze allettanti ma non prive di rischi. D’altra parte, la partenza soprattutto maschile da queste valli verso le città pakistane è un fattore incontrovertibile, come pure le unioni fra uomini musulmani e donne kalash che implicano, con la necessaria conversione a scopo matrimoniale, l’ingresso in una società dai valori diversi. In particolare la componente femminile è oggi chiamata a mutamenti difficili, quasi sempre radicali.
Le ragazze kalash che scendono nella valle di Chitral per gli studi superiori e universitari lasciando un ambiente sociale che non le discrimina – se si esclude la breve segregazione in appositi edifici durante il periodo mestruale, del parto e post parto – devono indossare una divisa conforme alla prassi islamica ed evitare di esporre il proprio corpo e la propria origine per evitare l’esclusione. Una scelta, quella fra radici e integrazione, che si accentua ancor più con l’eventuale necessità di trasferirsi lontano dall’area di origine, dove una donna sola e indipendente, senza una tutela maschile, è di fatto emarginata o malvista.
Articoli correlati

Arcipelago vivo

Il Giubileo visto dalla Cina