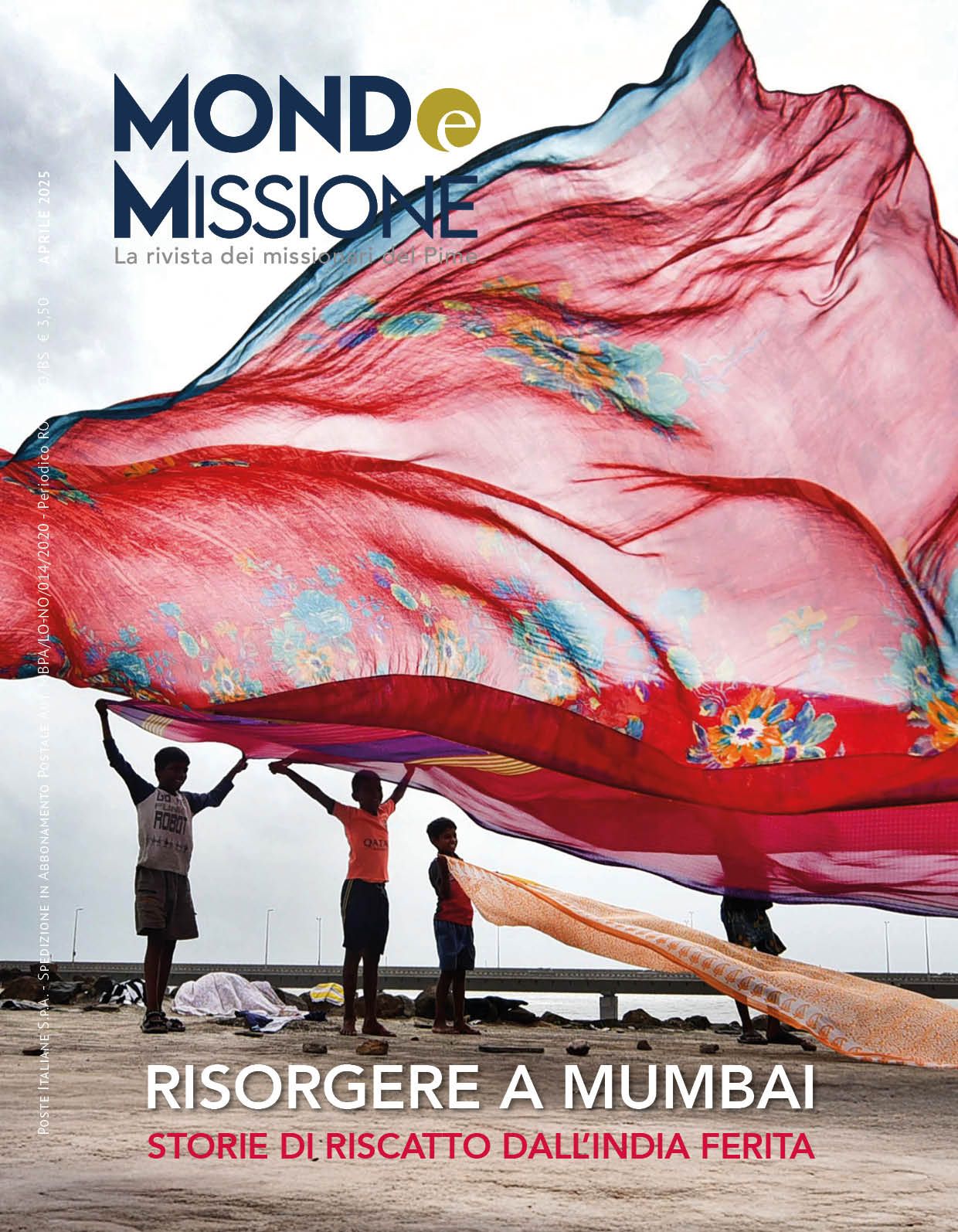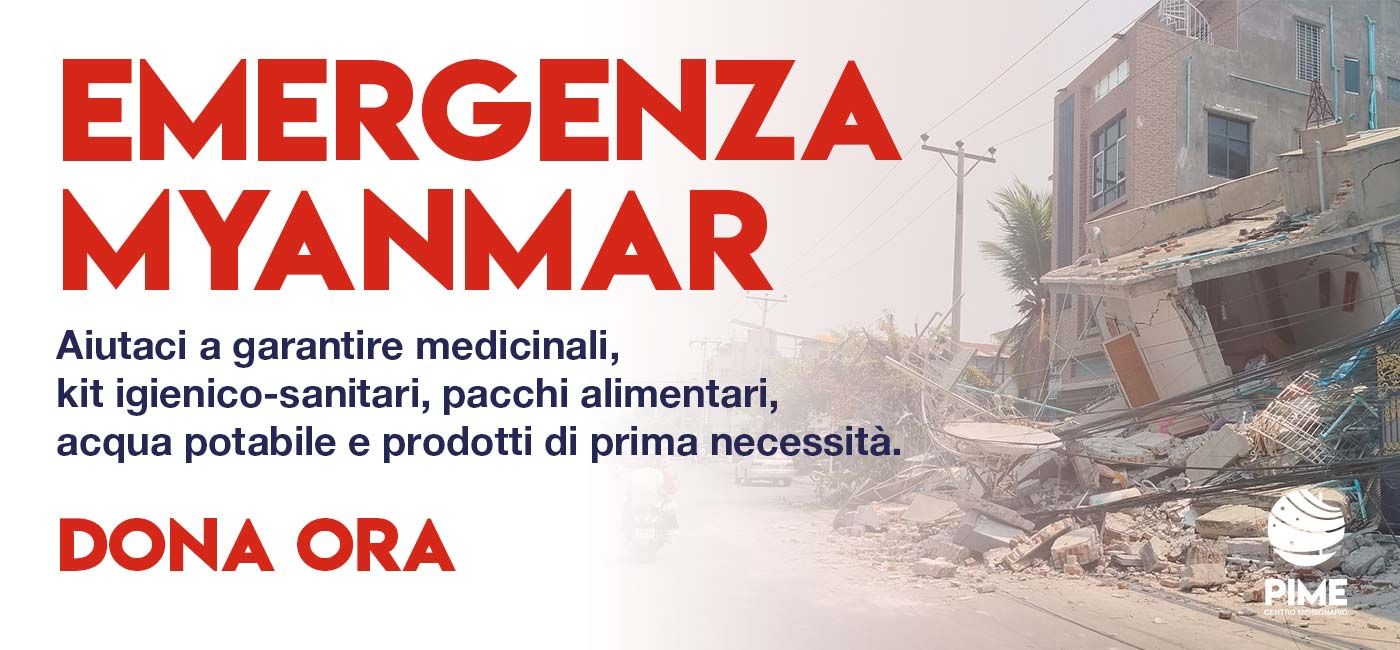Schegge di storia 1 – Passare il Gange
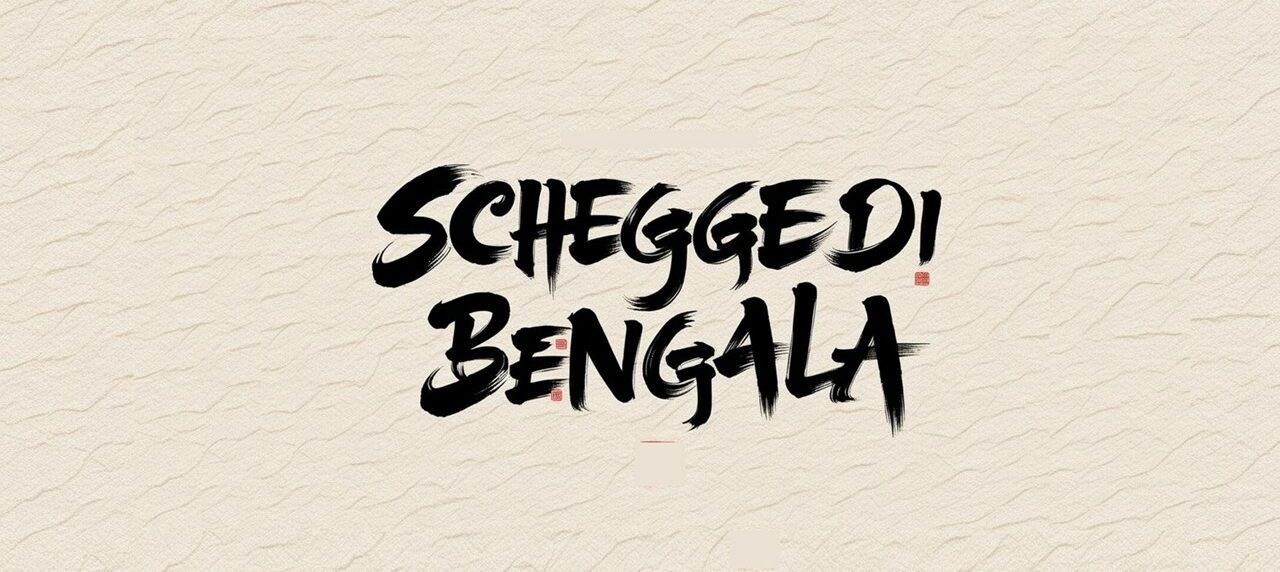
«Siamo dove dovremmo essere, e facciamo ciò che dovremmo fare?». Con queste due domande-slogan, qualche anno fa la direzione generale del PIME propose di preparare l’Assemblea Generale dell’Istituto, che si svolge ogni sei anni, per verificare come si sta andando avanti, orientarsi per il futuro, eleggere la nuova Direzione.
A domande del genere non si risponde una volta per tutte: la realtà cambia e le domande ritornano, anche se sotto forme differenti. E sono importanti: per questo ho pensato di preparare qualche “Scheggia di storia”, con l’intento non di scrivere che cosa è successo esattamente in quell’anno, mese, giorno e chi ne era partecipe: non aspettatevi questa lodevole precisione perché non la troverete. Cercherò di fare (a memoria e senza consultare documenti e calendari) una sommaria storia degli avvenimenti e delle idee che hanno motivato le scelte fatte dal PIME da quando – con il nome di “Seminario per le Missioni Estere di Milano” – ha messo piede in Bengala.
Nel 1978 – l’anno in cui per la prima volta venni in Bangladesh – era nei sogni, nei propositi, e nelle velleità dei giovani l’espressione “alla ricerca di vie nuove”. C’era il desiderio di non limitarsi ai tipi di presenza missionaria seguiti fino ad allora, perché, sostenevano, ci eravamo concentrati sul “già fatto” per migliorarlo e per dare continuità, ma avevamo trascurato la nostra vocazione, che ci chiede di “andare oltre”: siamo venuti in un Paese con pochissimi cristiani, ma se ci curiamo soltanto di loro non possiamo dire di essere davvero missionari “ad gentes”, cioè fra i non cristiani.
Quando, nel 1855, i primi missionari arrivarono al Bengala Centrale, esso faceva parte dell’India, colonia britannica; successivamente, attraverso non poche tragedie, passò dalla tutela britannica ad un’indipendenza (1947) che si rivelò ingannevole: ora il Bengala orientale costituiva la parte est del Pakistan, un improbabile paese formato da due aree (Est e Ovest) tenute insieme solo dalla religione Islamica, e separate da migliaia di chilometri di territorio indiano, oltre che da tradizioni, lingue, culture diverse. Era una nazione “artificiale” destinata a spaccarsi, come infatti avvenne nel 1971, dopo 10 mesi di sanguinose lotte, quando – con l’aiuto dell’India – la parte est conquistò l’indipendenza, assumendo il nome attuale: Bangladesh. Seguirono una serie di colpi di stato e periodi di democrazia poco convincente… fino ad oggi, quando il Bangladesh si è trovato, all’improvviso, a dover gestire i postumi di una rivolta popolare, di massa, avviata e pilotata – almeno per quanto si può sapere – dagli studenti universitari, che ha letteralmente spazzato via tutta la classe dirigente politica e burocratica, e parte delle risorse imprenditoriali degli ultimi 15 anni. Alcuni vorrebbero mettere in discussione persino il nome e la bandiera del Paese, che con grande incertezza cerca i passi da compiere per reimpostare se stesso.
Quanto a noi missionari, siamo arrivati nel Bengala “britannico” nel 1855 con un piccolo gruppo che incominciò a guardarsi intorno in un’area a nord di Calcutta, orientandosi verso est e operando nei villaggi vicini a Jessore (attualmente parte del Bangladesh, diocesi di Khulna), per lo più fra gruppi di cristiani “protestanti”, di hindu, e di musulmani, a sud del fiume Gange. I nostri missionari frequentavano i luoghi più poveri offrendo istruzione e assistenza ai malati, e facendo progressi anche in termini di nuovi battezzati o di gruppetti che entravano nella chiesa cattolica.
A fine 1800, un viaggio in treno fu all’origine di un cambiamento imprevisto. Un tribale Santal trovò posto accanto ad un nostro missionario e, presentandosi come cristiano cattolico, lo invitò a recarsi al suo villaggio, dove molti desideravano conoscere il cristianesimo. Il missionario lo seguì, visitando quello che divenne il primo villaggio cristiano nella regione “Uttorbongo”, area bengalese a nord del Gange. Numerosi altri seguirono, non soltanto Santal, ma anche appartenenti ad altri gruppi tribali. Attratti da questa disponibilità, entrando nel XX Secolo, i missionari del PIME chiesero e ottennero dalla Santa Sede di passare ad altri la responsabilità del sud, per spostarsi tutti a nord del Gange. La zona sud venne pastoralmente seguita da Gesuiti e Salesiani che già erano presenti in aree vicine, finché i Saveriani ne accettarono la responsabilità e diedero il primo Vescovo alla nuova diocesi di Khulna.
Nella nuova area loro affidata, i missionari del PIME, a differenza di vari missionari protestanti, focalizzarono la loro presenza sui villaggi. Si trattava di una scelta quasi obbligata, perché coloro che ci avevano invitato là, chiedendo poi il battesimo, vivevano in villaggi sparsi, mentre nelle città risiedevano Bengalesi musulmani o hindu. Ci fu un rapido sviluppo, e già nel 1927 Dinajpur, una cittadina che era poco più di un grosso villaggio, venne scelta come sede di una nuova diocesi, perché era in posizione più o meno centrale rispetto alle località dove si trovavano gruppi di cristiani.
In queste condizioni, si praticava un metodo di evangelizzazione e di pastorale che potremmo dire “nomadici”. I missionari chiamavano “mofussol” (campagna) le visite ai loro parrocchiani o catecumeni in luoghi anche molto remoti, raggiungibili solo su strade sterrate, polvere nella stagione asciutta e fango nella stagione delle piogge, viaggiando su carri trainati da buoi; in molti casi rientravano nel villaggio che costituiva la “sede centrale” solo dopo settimane di lenti trasferimenti. In ciascun villaggio erano ospiti di qualche famiglia, oppure alloggiavano in precari ambienti affiancati alla cappella, costruita con la collaborazione dei nuovi cristiani.
Le visite erano certamente scomode, ma fruttuose, perché le tappe relativamente lunghe permettevano di accostare tutte le famiglie, cristiane e non, venendo a conoscerne problemi e desideri, e di fare catechesi, praticare un po’ di “medicina” di base, cercare di proteggerli da chi voleva sottrarre loro le terre; insomma, si entrava nella vita di quella gente, quasi ovunque organizzando piccole scuole elementari, e “dispensari medici” gestiti dalle suore di Maria Bambina (e successivamente anche dalle Missionarie dell’Immacolata-PIME) che erano arrivate offrendo un aiuto indispensabile. Nacque anche, a Dhanjuri, non lontano da Dinajpur, un ospedale per la cura della malattia allora più temuta di tutte, la lebbra, mentre a Dinajpur prese pian piano forma e dignità di ospedale il St. Vincent Hospital, con annessa scuola infermieristica un piccolo, avviato da padre Bonolo “alla buona”, come “rifugio” che accoglieva ammalati che avevano bisogno – più che di medicine – di riposo e soprattutto di una buona nutrizione.
Più tardi, il miglioramento delle strade e la possibilità di usare la motocicletta resero più rapidi gli spostamenti, e le visite divennero più frequenti; ma spesso diventavano anche frettolose, e brevi; perciò più superficiali e forse meno efficaci.
(continua)
Articoli correlati

La mia missione con i “diversi” del Roraima

Myanmar, la preghiera dell’arcivescovo di Mandalay