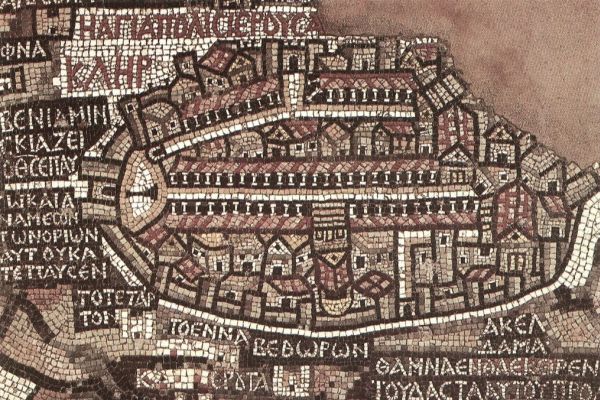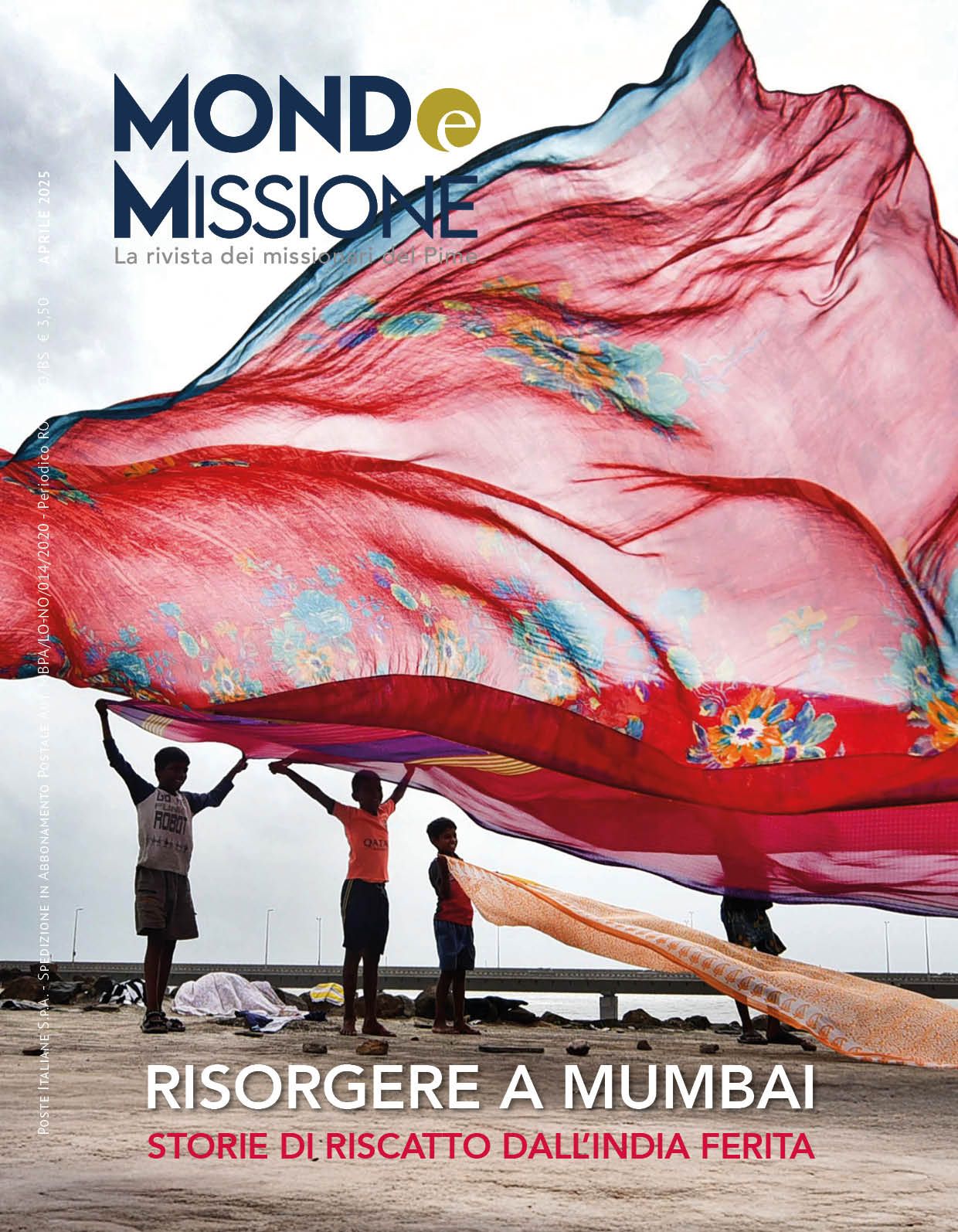Laboratori di fraternità, germogli di speranza

A Milano, a pochi passi dai locali degli aperitivi, c’è un appartamento dove alcuni giovani stanno facendo un’esperienza di vita comune. Lo chiamano “laboratorio di fraternità”. E non è il solo…
Ad aprire la porta in via Correggio è Giulia Gianola, classe 1997, capelli corti e neri, un sorriso accogliente. È tornata da poco dalla sua giornata di servizio civile al Centro Pime, presso l’ufficio mondialità dove segue i ragazzi del doposcuola Time Out. Originaria di Premana, in provincia di Lecco, vive a Milano da poco più di sei mesi.
Ci fa strada sino al secondo piano, dove c’è l’appartamento che condivide con altri ragazzi e ragazze: Sabrina, Pietro, Jacopo, Karol e Marie. Qualcuno è in casa, ma giusto il tempo di una veloce presentazione: c’è chi deve scappare al lavoro e chi prendere un treno. «Sei capitata proprio con chi non sa cucinare!», commenta ridacchiando Giulia, riferendosi a lei e al suo coinquilino Pietro Fossati – 26 anni, di Sesto San Giovanni – appena uscito dalla stanza.
Prima di mettersi ai fornelli, Giulia propone di salutare suor Lydia Cramarossa, religiosa della Congregazione delle Suore di Nazareth, che mettono a disposizione dei ragazzi l’appartamento del primo piano della loro villetta. È lei ad accompagnare il cammino spirituale di questi giovani: «Quest’anno – spiega – hanno scelto di leggere insieme il Vangelo di Marco per condividere le riflessioni e conoscere in modo più profondo la persona di Gesù e il suo messaggio di speranza e di amore per tutta l’umanità in particolare per i più “piccoli”».
La casa di via Correggio reintra in un’iniziativa della Pastorale Giovanile di Milano, che mette a disposizione alcuni appartamenti a ragazzi fra i 19 e i 30 anni che vogliono sperimentare uno stile di vita alternativo, in cui la quotidianità è attraversata dal desiderio di condivisione e di fede. La comunità di Giulia, inoltre, aderisce alla proposta di “Vita comune per la carità”, promossa sempre dalla Pastorale giovanile insieme a Caritas Ambrosiana per offrire ai giovani la possibilità di mettere la carità stessa a fondamento della loro quotidianità. «Lo scopo del progetto è quello di imparare a vivere in comunità e aprirsi al servizio dei più poveri», continua suor Lydia. Questa finalità si traduce in un impegno concreto di servizio che i ragazzi scelgono di fare, in base alle proprie attitudini e disponibilità, su ambiti diversi: grave emarginazione, carcere, migranti, persone con disabilità, minori. Ogni giovedì mattina, ad esempio, Giulia presta servizio nella mensa dell’Opera Messa della Carità, fondata dai Carmelitani scalzi, all’Arco della pace: «È un dare senza ricevere e va bene così, è un servizio! Serve anche a quello», sottolinea. «Attraverso il dono agli altri si impara ad amare se stessi e le altre persone», commenta Pietro, impegnato nella mensa dei poveri a Baggio, gestita dalle Missionarie della Carità: «Il valore più grande che mi sta dando questa esperienza sono i rapporti che si creano: ti fanno sentire guardato, chiamato per nome».
Dopo la chiacchierata e qualche dolcetto con suor Lydia, è il momento di tornare nell’appartamento e preparare la cena: il menù della casa propone gnocchi al gorgonzola. Ma come sta andando questa vita comune che Giulia e Pietro e i loro coinquilini hanno scelto? «È un po’ come la missione – risponde Giulia, partita l’estate scorsa per la Thailandia, dopo il primo anno del cammino di “Giovani e Missione” proposto dal Pime – tu scegli l’esperienza, non le persone con cui stare. Ti vengono “date” e tu le accogli. Ti fidi. Possono essere persone che non avresti mai incontrato». «Questa esperienza mi sta aiutando a vivere la quotidianità e la vita per come è per davvero – continua Pietro -. Mi sta insegnando a stare in tutte le sfumature della vita, in tutti i suoi colori. Era uno dei motivi che mi hanno spinto di casa: prima avevo la tendenza a immaginare che tutto ciò che era al di fuori fosse bello e perfetto. In realtà, ho scoperto che ci sono tante “tonalità”, come imparare a convivere con il diverso».
In via Correggio, del resto, convivono sei ragazzi con sei temperamenti diversi. Ognuno ha la sua storia. «Le diversità ci sono – conferma Giulia -, ma sei chiamato a prenderti cura dell’altro che vive in casa con te. È un’esperienza molto umana che ti porta a metterti in gioco. Impari a fare casa e a fare famiglia». Insomma, non si dividono solo le spese di luce e gas: c’è molto di più.
Dalle loro parole si capisce quanto le vite comuni non siano “esperienze ideali”, ma di vita concreta con tutte le sue fatiche. «Il fatto di aver scelto ci aiuta a dire “ok abbiamo litigato, parliamone”. Non significa però che sia facile» spiega Giulia, mentre serve gli gnocchi immersi nel gorgonzola. Ne lascia un po’ da parte per Sabrina, un’altra coinquilina che sarebbe rientrata a breve da un weekend fuori porta, dopo aver discusso la tesi triennale in Scienze dell’educazione. Non passa molto tempo e si sente infatti che qualcuno entra in casa: è prorpio lei, Sabrina Dondè, 22 anni, che esordisce dicendo: «Quando sono arrivata in stazione e ho preso la metro per venire qui, mi sono proprio detta “che bello tornare in un posto che puoi chiamare casa!”». Per lei, Milano, in realtà, era già “casa”: fino a qualche mese fa ci viveva con la famiglia. Eppure, la voglia di uscire dalla propria “bolla” era tanta, ammette: «Le caratteristiche di questa città, come la frenesia, la competizione o l’individualismo, cozzavano con me e quindi ero alla ricerca di uno stile di vita più mio, più “sociale”. Volevo prendere la mia vita in mano». Così è arrivata in via Correggio: «Essere qui è proprio l’apice di quello che voglio e di come penso la vita. Questa esperienza mi sta insegnando a sentire che la vita è mia e che sono io a camminare con i miei passi e a fare i conti con me stessa».



Ad aiutare i ragazzi in questo cammino comune c’è don Marco Fusi, responsabile del Servizio per i giovani e l’università dell’arcidiocesi di Milano. «Già da diversi anni ci sono state brevi esperienze di fraternità nelle parrocchie – ricorda il sacerdote – Cogliendo i desideri che emergevano dai racconti dei ragazzi abbiamo iniziato a favorire soggiorni comunitari più lunghi. Ci siamo ispirati a Casa Legàmi, l’esperienza di vita comune nell’ex-canonica della parrocchia santa Brigida di Camerlata, messa a disposizione dei giovani dal parroco don Giusto Della Valle».
Sviluppando quell’idea, sono nate successivamente diverse proposte anche in base alle esigenze dei giovani. Ci sono infatti le già menzionate case di “Vita comune per la carità”, a Milano (oltre a via Correggio, anche in Corso Garibaldi presso la parrocchia santa Maria Incoronata e presso la parrocchia Tre Tronchetti) e a Cernusco sul Naviglio, dove c’è Casa Nazareth, nella parrocchia Madonna del Divin Pianto.
Nel capoluogo lombardo ci sono inoltre altre due iniziative, chiamate Rosa dei venti e Casa Magis. La prima è un’esperienza di vita comunitaria orientata al discernimento della propria vocazione. «Nelle parrocchie di san Gregorio Magno, di santa Maria del Rosaio e di S.Rita a Corvetto – spiega don Marco – i giovani sono accompagnati ad acquisire strumenti per leggere la propria vita alla luce della fede ed a interpretarla per le scelte che sono chiamati a compiere. In questi casi, la diocesi si avvale della corresponsabilità apostolica dell’Azione cattolica ambrosiana». Casa Magis, invece, si trova presso la parrocchia di sant’Eustorgio, vicino alla vita mondana dei Navigli, ed è nata per sperimentare la dimensione dell’accoglienza per altri giovani.
Oltre agli esempi milanesi di vita comune ci sono anche Casa Hermon, presso il Centro pastorale ambrosiano di Seveso, e Cafarnao, nella parrocchia di San Rocco a Monza. «Un paio di volte all’anno si organizzano degli incontri formativi, delle “scuole di spiritualità” per i giovani di tutte le esperienze di vita comune – spiega il responsabile – sono momenti di confronto molto utili per ragazzi che hanno gli stessi desideri, profondi e alti».
Dopo quattro anni di “laboratorio di vita comune”, si cominciano a vedere diversi “frutti”. «Innanzitutto – continua don Marco – queste esperienze possono rappresentare un segno di fraternità per altri giovani e per la Chiesa stessa, dunque un esempio di vita più piena e “umana”. Inoltre, permettono di sperimentare uno stile di vita nella quotidianità. Non è un’esperienza sporadica di uno o due giorni. Non è un’oasi di poche ore, ma un esercizio continuo di uno stile di vita, che poi rimane tuo e diventa un “abito” anche quando l’esperienza finisce».
Le proposte di vita comune, infatti, durano un anno, non solo per dare la stessa possibilità a più persone, ma anche e soprattutto «per “scomodare” i giovani a fare una scelta che nasca dall’esperienza e non si “accomodi” troppo. Non deve diventare una comfort zone», precisa don Marco. Infine, tra i risultati di questi primi anni si vede anche la capacità di questi giovani di riuscire a costruire la propria vita come adulti: «L’orizzonte vocazionale dell’esperienza passa anche attraverso la presenza di alcune figure, che accompagnano e li aiutano a leggere se stessi e la presenza della Parola di Dio, l’elemento della vita spirituale. I giovani sono così chiamati a scegliere, a diventare grandi e a costruire la loro vita». Le esperienze di fraternità sono quindi dei «segni promettenti – conclude don Marco, – o meglio, volendo utilizzare le parole del Giubileo di Papa Francesco, sono dei germogli di speranza».
Articoli correlati

Quando un padre diventa un aguzzino

La “chitarra del mare” suona note di speranza