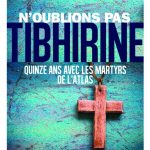Tibhirine, sguardi incrociati

A 22 anni dal rapimento dei monaci di Tibhirine, in Algeria, padre Jean-Marie Lassausse ricorda i quindici anni passati nel monastero, fra strette misure di sicurezza e nuove prospettive di dialogo. Intanto, si prepara la beatificazione di tutti e 19 i martiri cristiani d’Algeria
Nella notte tra il 26 e il 27 marzo 1996, sette monaci trappisti del monastero algerino di Tibhirine vennero rapiti e successivamente assassinati. Ora, a ventidue anni di distanza, il loro martirio, così come quello di altri dodici tra religiosi e religiose uccisi in Algeria in quegli stessi anni – tra cui il vescovo di Orano Pierre Claverie – è stato riconosciuto dalla Congregazione per le cause dei santi. Saranno beatificati entro la fine di quest’ anno, come ci aveva raccontato il postulatore della causa di beatificazione, il trappista Thomas Georgeon, sul numero di gennaio di Mondo e Missione. Intanto, la loro testimonianza e il loro messaggio continuano a rimanere vivi e attuali, anche grazie all’impegno di chi, come padre Jean-Marie Lassausse della Communauté Mission de France, ha dato continuità per quindici anni, anche se in forma diversa, alla presenza nel monastero di Tibhirine. Come racconta nel suo nuovo libro appena uscito in Francia: “N’oublions pas Tibhirine” (Ed. Bayard). Non dimentichiamo Tibhirine. Oltre che un titolo, un impegno, non solo per la Chiesa d’Algeria, ma per la Chiesa universale. Ne pubblichiamo alcuni stralci. * * * Tibhirine, in Algeria, è diventato il simbolo dell’incontro fraterno tra due società, due culture, due religioni, grazie alla presenza di una comunità cistercense che ha dato la vita per i fratelli algerini durante gli anni bui. Tibhirine è conosciuto per il dramma che vi ha avuto luogo, ma anche per una presenza monastica di quasi sessant’anni consecutivi, in cui i monaci – cistercensi di stretta osservanza – hanno condotto una vita di relazioni con la popolazione del villaggio. Legami di amicizia molto forti si sono creati tra gli abitanti del villaggio e i padri, i babass, come diceva la gente di qui. Questo libro vorrebbe condividere il mio vissuto, risultato di quindici anni di presenza e di incontro con una popolazione fraterna con la quale ho intrecciato legami, costruito amicizie, anche se io non sono un monaco, ma un semplice sacerdote-contadino della Communauté Mission de France. Agli antipodi di qualsiasi forma di proselitismo, l’incontro radicato nella vita di tutti i giorni diventa fecondo se i due partner si impegnano risolutamente a entrare nello sguardo dell’altro, se condividono “il pane e il sale” secondo la bella espressione del domenicano Serge de Beaurecueil. In questo monastero di Tibhirine, uomini come me e come loro hanno vissuto la vita di tutti i giorni. Hanno lavorato la terra generosa, con acqua altrettanto generosa e assolutamente fondamentale a Tibhirine. Al ritmo della preghiera monastica, i monaci hanno lodato l’unico e vero Dio, come i loro fratelli musulmani che rispondevano alla preghiera del muezzin, la cui voce sorgeva ogni giorno da Tamezguida, poiché non avevano neppure un luogo di preghiera nel loro villaggio. In quegli sguardi incrociati, nel lavoro, al mercato, nei pasti condivisi, all’ora del caffè ogni mattina, l’inesprimibile dell’uomo è riuscito ad esprimersi, lasciando ancora oggi delle tracce. Per quindici anni, mi è stata data la missione di vivere in questo luogo giorni felici e giorni bui, con il cielo basso, come nelle brevi giornate invernali, quando non è possibile distinguere neppure colui che lavora al tuo fianco, tanto la nebbia è fitta. Potrei anche indicare una data che ha segnato una sorta di cambiamento, rompendo questa semplicità del “vivere insieme”: il 6 marzo 2006. Fino a quel giorno, ero libero nei miei movimenti, nelle visite, nei viaggi di andata e ritorno da Algeri. E poi un giorno, c’è stata quella telefonata dal ministero degli Interni che chiedeva fossi scortato dalla gendarmeria durante i miei viaggi. Per quale motivo? Quale contesto potrebbe aver portato a tale decisione? I fili sono aggrovigliati, ma il quadro e le circostanze si sono un po’ illuminati. Anche per questo, e per tutti coloro che hanno a cuore il futuro di Tibhirine, penso sia giunto il momento di condividere i miei sentimenti, le mie convinzioni, il mio cammino interiore, e anche le mie domande. «È da molto tempo che non scaviamo il nostro pozzo», aveva detto un giorno Mohamed a padre Christian de Chergé. Sì, si tratta proprio di scavare insieme, di bere dalla stessa fonte. Ci sono due fonti importanti a Tibhirine: quella che dà acqua alla popolazione e che è stata data anche ai cistercensi, “El Gôzat”. E quella all’interno della clausura, “El Margouma”, il castagno. Dio stesso si dona a ogni uomo. Per me è stato il condividere il pane caldo, cotto a casa, con il sale, simbolo per gli arabi dell’amicizia e dell’ospitalità. Oppure, detto altrimenti, è stato salire insieme la scala mistica del dialogo. Il punto d’appoggio di questa scala è nei cieli, fondato sulla comunione dei santi. Condividere il banchetto di nozze, ogni giorno, su una tavola semplice, seduto su un blocco di cemento, significa aprire il campo dell’amicizia. Il pasto è il gesto che unisce e nutre sia il corpo che lo spirito. La condivisione del pasto: meraviglioso rito inter-religioso che è simbolico anche per gli agnostici incontrati all’interno del monastero. «Voi siete il sale della terra», ci dice il Nuovo Testamento. Oggi, a Tibhirine, è diventato difficile condividere il pane e il sale con gli abitanti del villaggio che, tuttavia, non chiedono altro che questo! La nebbia si è addensata negli ultimi due anni. Ma in realtà, la nebbia si è gradualmente inspessita sul monastero da una decina d’anni, con qualche schiarita. Prende la forma di misure di sicurezza sempre più stringenti, che ci obbligano, innanzitutto, a non attraversare il recinto degli otto ettari che coltiviamo ancora con due collaboratori, Youcef e Samir, senza i quali nulla sarebbe stato possibile. Nonostante questi vincoli, è importante per me trovare l’opportunità di rendere qualche servizio e di fuggire per pochi minuti nel villaggio, per rivedere e salutare gli amici che mi hanno adottato come uno di loro… Non mi dicono forse: «Tu sei il figlio di questa terra. Ibn al balad»?. Un giorno un amico mi disse: «Per quindici anni hai tenuto un piede sulla porta del monastero in modo che non si chiudesse definitivamente». Penso che sia profondamente vero. Porta aperta ai visitatori in modo che potessero entrare e vivere per un momento, un’ora o una giornata un senso di libertà così ricercato nel monastero. Porta aperta in modo che io potessi uscire ogni giorno per andare al villaggio anche per un nonnulla; ma questo nonnulla è tutto quando si vive rinchiusi senza la possibilità di bere un bicchiere di tè o di caffè con gli amici o di trovarne di nuovi nella semplicità del quotidiano. Porta socchiusa in modo che l’aria della strada, la vita del villaggio, le informazioni, la condivisione di gioie e sofferenze arrivassero all’interno del monastero… Monastero che è ben solido. Ma il suo ruolo di ponte, di spazio di libertà per tutti, ha bisogno di un secondo pilastro sul quale possa sostenersi: quello della convivialità e dell’amicizia. Nel mondo ci sono ancora oggi circa 40 mila chilometri di muri di cemento, filo di ferro e sabbia che separano popoli, etnie, uomini. Tibhirine non deve diventare il simbolo della clausura o della chiusura, ma aprirsi di nuovo a un futuro di amicizia nata dalla vita e dal martirio dei monaci.Articoli correlati

Dalla Guinea-Bissau, l’addio a Papa Francesco
Ha scelto la Guinea-Bissau, ha scelto i piccoli, ha scelto gli ultimi, quelli dimenticati, perché questo era e sarà s…

Papa Francesco è morto
Poco fa sua eminenza, il card. Kevin Farrell, prefetto del dicastero per i Laici e camerlengo di Santa Romana Chiesa,…

Bezerra Da Cruz: croce e speranza nel Nord-est brasiliano
La crocifissione dell’artista João Batista Bezerra da Cruz, ambientata nello Stato di Piauí, esprime la forza di esse…