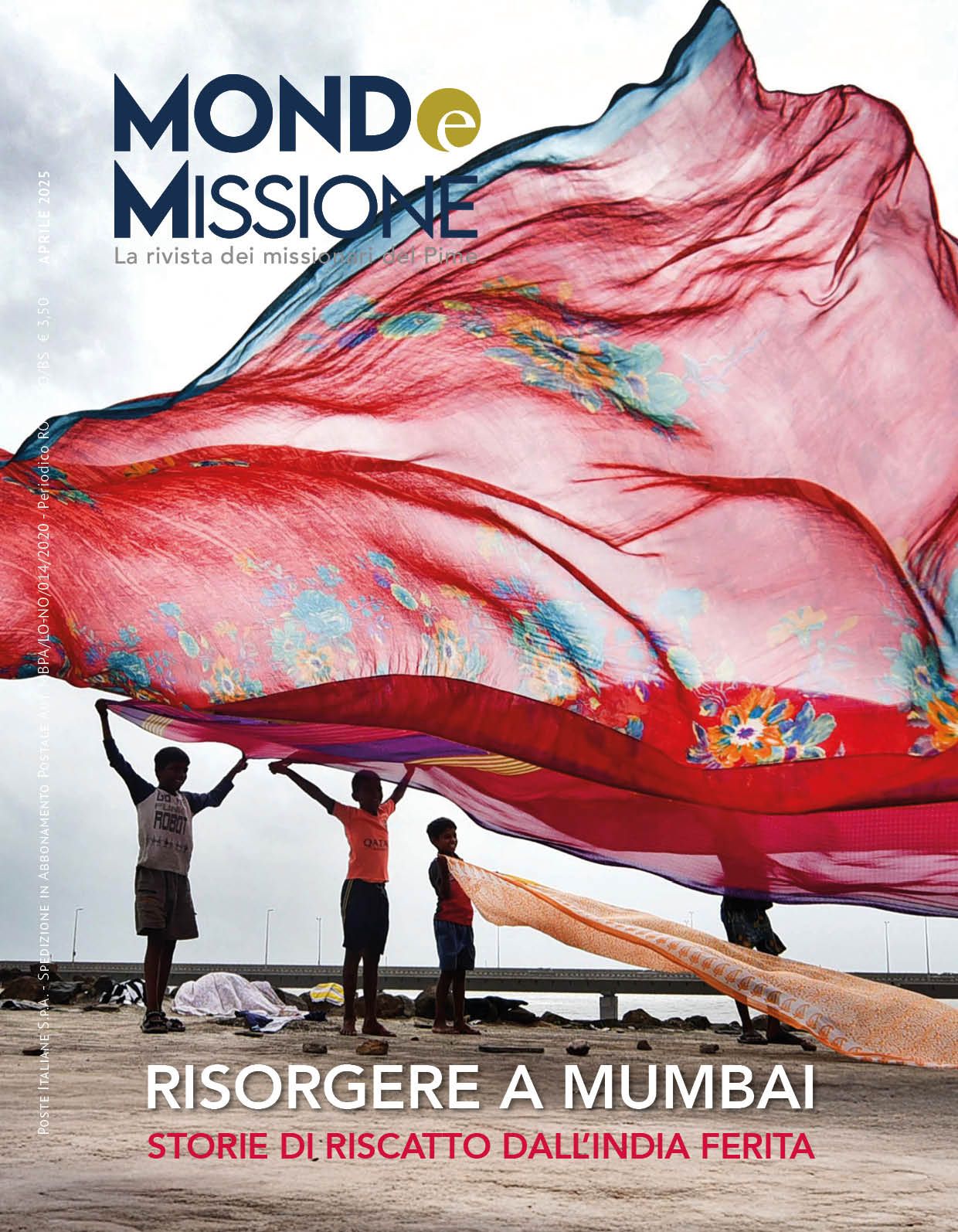Liberiamo le migrazioni dalle passioni

È l’invito lanciato in occasione della presentazione del 30° Rapporto sull’immigrazione di Fondazione Ismu, che evidenzia il consolidamento di una presenza stabile di quasi 6 milioni di immigrati nel nostro Paese. Ma non mancano le criticità, soprattutto in ambito lavorativo. Così come non mancano pregiudizi e strumentalizzazioni
«Una società profondamente mutata nel corso degli ultimi tre decenni, e che sta progressivamente metabolizzando la sua evoluzione in una società multietnica e multireligiosa, non senza fatiche e conflitti». Così Nicola Pasini, segretario generale della Fondazione Ismu, ha presentato ieri, il 30° Rapporto sulle migrazioni. Un rapporto che, oltre a fotografare la situazione attuale, offre uno sguardo e molte riflessioni sull’evoluzione di un fenomeno che è cambiato nel tempo e ha cambiato la nostra società.
Oggi sono quasi 6 milioni (5.755.000 per la precisione con un leggero calo dello -0,3%, di cui circa 300 mila irregolari, anche questi in diminuzione) i migranti stabilmente residenti nel nostro Paese. La loro presenza, che si intreccia a vicende storiche e a congiunture geopolitiche mondiali, ha visto affiancarsi alle prime generazioni sia le seconde, oggi adulte e avviate a dare vita alle terze, sia le numerose acquisizioni di cittadinanza, che hanno prodotto quasi due milioni di “nuovi italiani”.
Inevitabilmente, la presenza di popolazione con background migratorio sta avendo un impatto importante su diversi ambiti: dalla scuola al mercato del lavoro, dalla sanità pubblica al welfare. Il tutto mentre sono cambiati gli atteggiamenti nei confronti dell’immigrazione, i discorsi e la propaganda della politica, il modo di raccontare l’immigrazione nei media, che purtroppo continua a focalizzarsi soprattutto sul tema-sbarchi.
Sbarchi che, in realtà, sono molto diminuiti nel 2024 (poco più di 66 mila, -57,9% rispetto al 2023), mentre sono aumentate le richieste di asilo (116 mila nei primi nove mesi del 2024, +27,1%), ma anche i dinieghi (63% nei primi nove mesi del 2023) e crescono le acquisizioni di cittadinanza.
«In questi trent’anni – spiega Livia elisa Ortensi, responsabile del settore statistico di Ismu – si assiste a una generale tendenza al consolidamento di presenze lungo residenziali, a una riduzione della componente irregolare, accompagnata da maggiore dinamicità e imprevedibilità legata ai flussi emergenziali». È il caso, ad esempio, dell’arrivo di circa 170 mila profughi ucraini nelle settimane e mesi immediatamente successivi allo scoppio della guerra nel febbraio del 2022, che poi si è quasi completamente arrestato.
«Il tema del governo dei flussi – fa notare il professor Ennio Codini del Settore Legislazione – viene spesso legato alla disciplina della cittadinanza. Ma è un legame errato. La disciplina della cittadinanza riguarda l’accompagnamento dei percorsi di integrazione».
A questo proposito un ruolo fondamentale lo svolgono la scuola e il lavoro. Nell’anno scolastico 2022/23 il numero degli alunni con cittadinanza non italiana, nati all’estero e nati in Italia, si attesta a 914.860 presenze, corrispondenti all’11,2% sul totale degli iscritti (8.158.138) dalle scuole dell’infanzia alle secondarie di secondo grado. «Purtroppo – sottolinea Mariagrazia Santagati del settore educazione – si riscontrano ancora molte diseguaglianze su base etnico-nazionale. Ma gli alunni con background migratorio mettono in evidenza un problema che in realtà è di tutti, quello di uno svantaggio legato appunto alle diseguaglianze». Un problema specifico riguarda i minori stranieri non accompagnati (Mnsa): solo 1 su 5, infatti, ha avuto accesso al sistema scolastico italiano.
Sul fronte del lavoro nel 2023 gli occupati stranieri di età tra i 15 e i 64 anni sono 2 milioni e 317mila. Tra il 2005 e il 2023 il tasso di attività degli italiani è cresciuto dal 61,9% al 66,4%, mentre la componente straniera è passata dal 73,4% al 69,6%. Il tasso di occupazione per gli italiani è cresciuto dal 57,2% al 61,2%, mentre per gli stranieri è diminuito dal 65,8% al 61,6%. L’incidenza degli stranieri sul totale dei disoccupati è pari al 15,5%.
«L’immigrazione – analizza Laura Zanfrini del Settore economia, lavoro e welfare – è una sorta di specchio che ci fa vedere cosa funzione e cosa non funziona, anche nell’ambito del mondo del lavoro. Cresce la platea di stranieri con sofferenza occupazionale e inattività. Quest’ultima riguarda soprattutto le donne. Le seconde generazioni scontano il paradosso dell’integrazione che offre prospettive limitate e, allo stesso tempo, scontano lo svantaggio derivante dal “cattivo lavoro” dei genitori. Quasi metà delle famiglie immigrate in Italia vivono in condizioni di povertà. E purtroppo si assiste a una sorta di “normalizzazione” del cattivo lavoro, attraverso, ad esempio, catene selvagge di subappalto. Questa questione non può essere ridotta al tema delle quote. I decreti flussi servono a creare irregolarità e sfruttamento», ammonisce la professoressa Zanfrini.
Ma com’è cambiato l’atteggiamento degli italiani in questi trent’anni? Secondo l’Eurobarimetro, il 48% pensa che gli immigrati contribuiscano positivamente alla vita del nostro Paese. Tuttavia, la temarica immigrazione risulta al quinto posto tra le questioni più importanti da affrontare insieme all’economia e dopo sicurezza e difesa, clima e ambiente, e salute. Per il 33% degli italiani, la gestione dell’immigrazione è tra le due principali politiche che potrebbero avere il miglior impatto positivo sulle vite degli intervistati dopo pace e stabilità (46%), cibo, salute e industria (27%). Il 48% degli intervistati ritiene che l’immigrazione extra UE sia un fenomeno negativo.
«Esiste ancora una discrepanza forte tra atteggiamento pubblico e comportamento personale – fa notare Giulio Valtolina del Settore religioni e famiglia -. Quando l’immigrato è il mio vicino di casa, il mio collega di lavoro, allora è una “brava persona”. Le relazioni personali diventano l’antidoto al pregiudizio e al luogo comune. Che invece esistono nella percezione pubblica. Ancora oggi, infatti, la percentuale della presenza degli immigrati in Italia è sovrastimata. Secondo Ipsos, si stima che gli immigrati siano il 21% della popolazione, mentre sono circa il 10%, e che i musulmani siano il 19%, mentre sono solo il 4%». Peraltro, la maggioranza della popolazione straniera presente in Italia continua a essere cristiana (53%), mentre i musulmani rappresentano quasi il 30%.
L’immigrazione, dunque, appare un problema per lo più quando è riferito alla collettività, ma in pochi lo percepiscono come una importante questione che impatta sulla propria vita. «Questo si riflette anche sugli atteggiamenti violenti nei confronti degli immigrati – continua Valtolina -. A questo proposito, l’Italia si colloca in fondo alla classifica europea». E per una volta è una buona notizia.
Articoli correlati

Dio cammina con il suo popolo

“La memoria degli oggetti” all’Eremo di Santa Caterina del Sasso