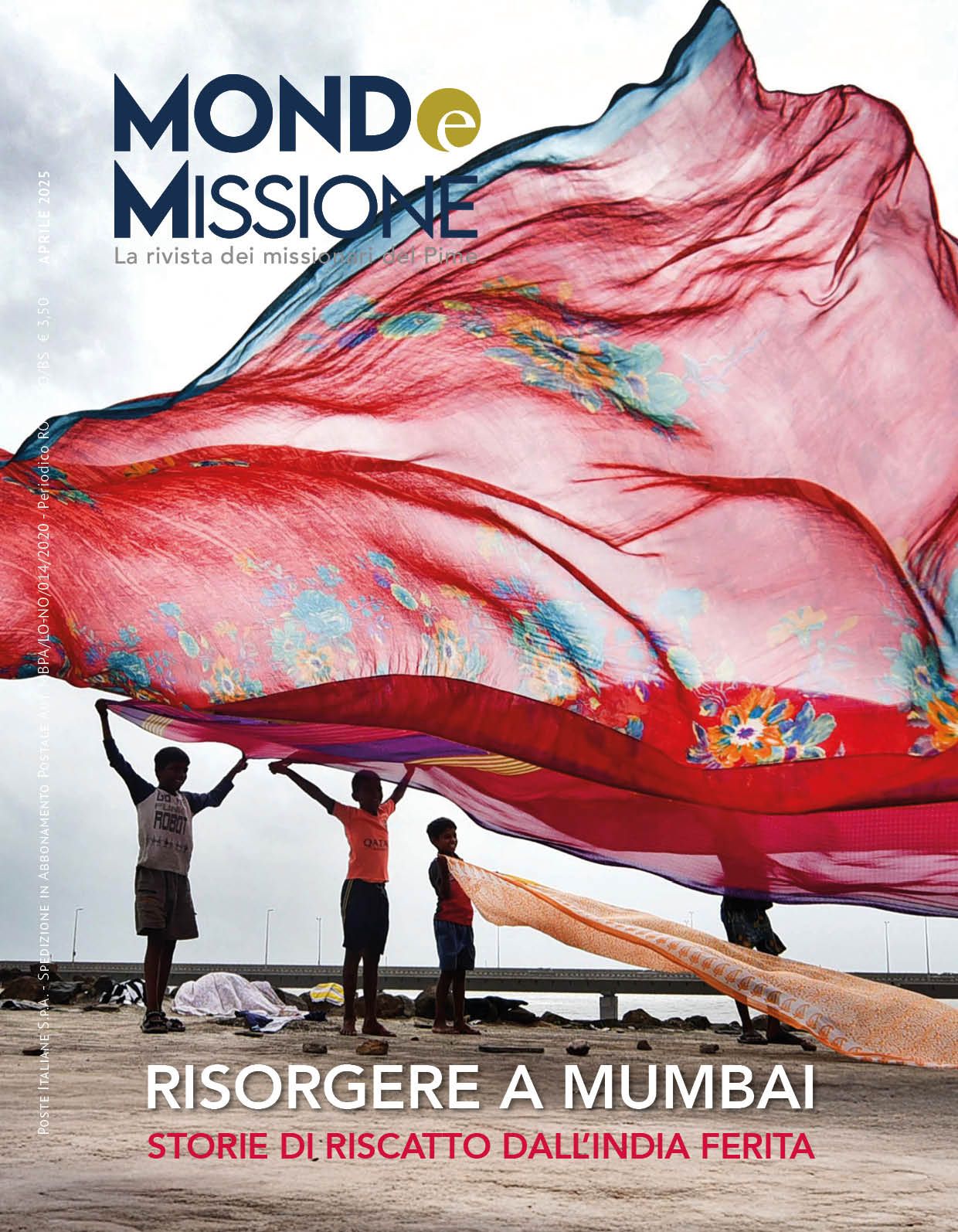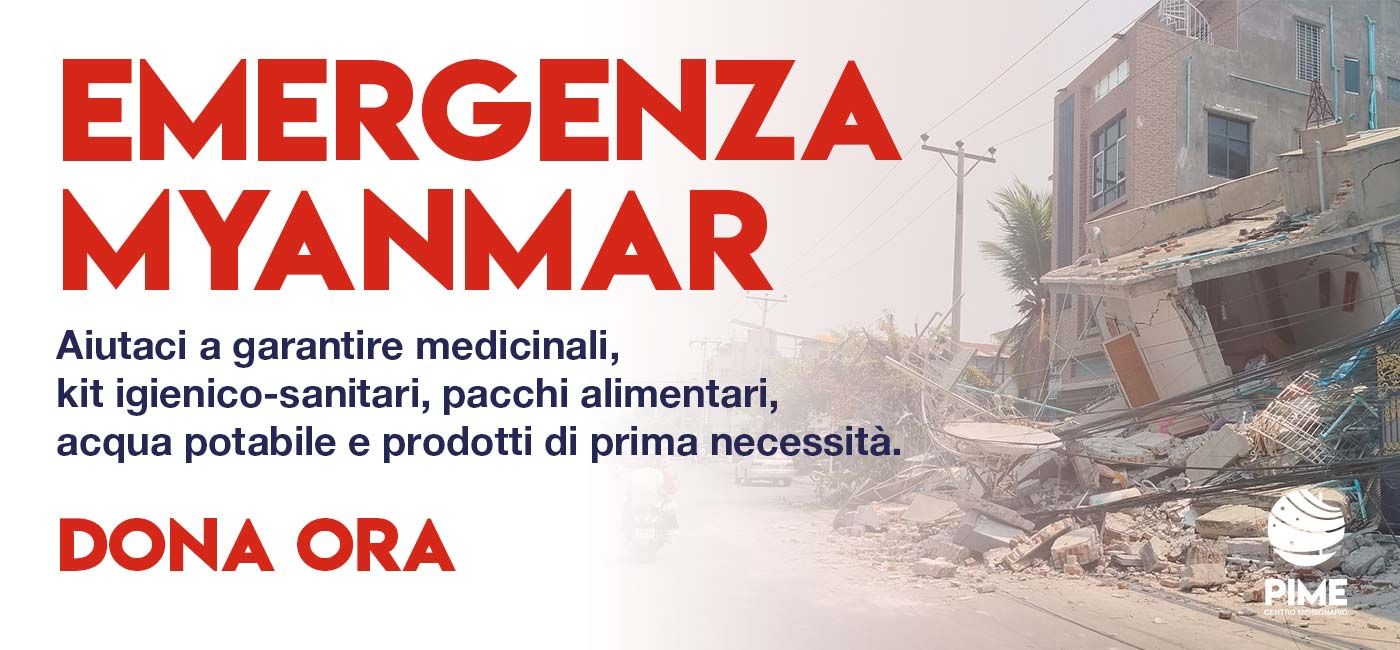Schegge di storia 3 – Prospettive nuove
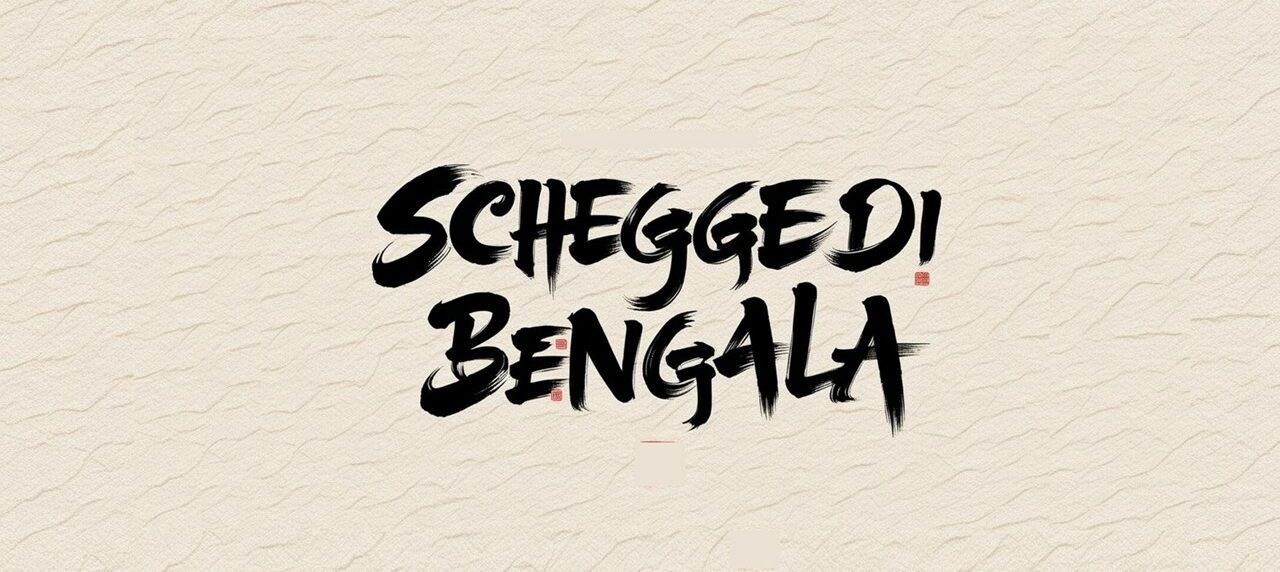
Il desiderio di capire, accogliere, mettere in pratica gli orientamenti offerti dal Concilio Vaticano II a proposito della missione della Chiesa, non solo mosse alcuni a cambiare il loro modo di essere presenti nei villaggi – come p. Corba, che si fece “contadino missionario” – ma offrì all’Istituto molti punti e stimoli per “andare oltre”. Fra di essi, era fondamentale una comprensione nuova del nostro rapporto con i credenti di altre religioni. Si parlò molto di “dialogo”, tema sviluppato anche da Paolo VI in un’enciclica scritta mentre il Concilio era in corso. Termine discusso, accolto con speranza, idealizzato, frainteso, temuto, che ha mobilitato esperti vari per commenti, spiegazioni, punti di vista innumerevoli. Anni dopo, un confratello anziano di cui avevo molta stima, ricambiata, mi scrisse una breve lettera per comunicare il suo profondo disagio, che riassunse così: “Mi pare che il dialogo sia un modo elegante per giustificare una vigliaccheria e non dover affrontare ostilità, rifiuti, persecuzioni”. Non mi fu difficile, nella risposta, citare anche un avvenimento allora recente: Padre Salvatore Carzedda, studioso e praticante di varie iniziative di dialogo nel sud delle Filippine, era stato ucciso da estremisti che vedevano proprio nel suo atteggiamento disponibile e cordiale, capace di un confronto sereno, un pericolo particolarmente grave per il loro radicalismo irrazionale.
Nel 1971 il PIME tenne un “Capitolo Straordinario” lungo e impegnativo, per rivedere se stesso alla luce degli orientamenti conciliari, verificare la propria fedeltà al carisma dei suoi inizi, valutare alcune scelte operate in oltre 120 anni di storia, colmare eventuali lacune. Furono rimesse in discussione, ad esempio, l’apertura di presenze e attività anche in paesi “cristiani” come il Brasile, di accogliere vocazioni dagli Stati Uniti e dall’India, il rapporto del PIME con la Chiesa italiana, di cui si voleva essere una “espressione missionaria”. Nell’intento di consolidare l’Istituto si erano avviate attività che alcuni non ritenevano appropriate per noi, come i seminari minori – che si decise di chiudere gradualmente, per rivolgere la nostra attenzione a giovani già capaci di una scelta di vita. Nelle Costituzioni dell’Istituto si introdussero compiti e finalità nuove, come l’impegno ecumenico, la collaborazione ad un processo di “inculturazione” (altro termine chiave di quel periodo) delle Chiese nei popoli di cui fanno parte. Scelte che andavano comprese, vagliate e realizzate secondo le situazioni in cui il PIME si trovava, in Paesi diversi e lontani fra loro.
In Bangladesh non mancarono le discussioni, e anche esperienze pratiche a volte controverse, ma comunque capaci- quasi sempre – di far compiere passi avanti forse meglio delle teorie. Il tutto comportò anche tensioni e incomprensioni, ma non si arrivò a fratture fra noi. L’esperienza di tre giovani a Bogra, già brevemente descritta nella “scheggia” precedente, fece capire che proporsi a persone di altre religioni semplicemente come “interessati a dialogare” non portava molto lontano; la strada che gradualmente si dimostrò percorribile fu quella di trovare, fra persone non cristiane, interessi, attività, obiettivi dove ci si poteva unire nel rispetto, nella reciproca conoscenza, che prendeva corpo anche operando insieme. Secondo me, questa ricerca condusse al punto in cui ci troviamo ora: non si parla più molto di dialogo, ma la mentalità è più aperta all’altro e a ciò che di positivo l’altro esprime: conduce a collaborazioni anche impegnative e a confronti anche abbastanza profondi.
Mi pare che oggi non ci siano dubbi: dobbiamo farci presenti non solo a chi richiede o accoglie volentieri l’annuncio (e questo discorso non va certo trascurato!), ma anche dove questa disponibilità non c’è, e quindi non è probabile che ci siano “conversioni”, e tuttavia ci può essere accoglienza reciproca e anche collaborazione nel bene, che già sono frutto dello Spirito.
In Bangladesh oggi il PIME dedica la maggior parte delle sue energie a sostenere o a formare parrocchie (e altre iniziative della Chiesa) vecchie e nuovissime, cercando di dare ad esse una dimensione aperta, in pratica di essere missionarie nel luogo in cui operano, e anche oltre. In esse si vive anche la carità che è testimonianza di autenticità del nostro impegno: scuole, dispensari medici, cooperative e tante altre iniziative ne sono l’espressione. Ma i nostri missionari cercano di fare attenzione anche a strade di bene che non partono solo da noi e che – come dicevo – non hanno come obiettivo diretto l’annuncio. “Gesù passò facendo del bene”, si trova scritto negli Atti degli Apostoli: non solo predicando. Il missionario non pretende il “monopolio” del fare il bene, anzi – lo condivide volentieri, senza mettere a tacere la propria identità, ma vivendolo come una testimonianza di ciò che significa per noi essere seguaci di Gesù e membri della Chiesa.
È da rilevare, tra l’altro, che in Bangladesh la Chiesa continua a crescere numericamente anche grazie a numerosi battesimi chiesti da adulti, e io sono convinto che molti si accostano al cristianesimo “per contagio” prima e più che per “annunci” espliciti.
Per me, il primo passo dopo il “fallimento” di Bogra consistette nel partecipare, a Dhaka dove risiedetti per un anno, agli incontri mensili di un gruppo informale di una trentina di musulmani e cristiani, interessati a conoscersi reciprocamente per capirsi, senza la pretesa di cambiare l’altro, piuttosto stimolando riflessioni basate sull’ascolto reciproco e non su pregiudizi. Un’esperienza modestissima, ma positiva e stimolante, che mi aprì la porta a qualche invito a parlare del cristianesimo in ambienti universitari islamici, e anche ad una visita all’Imam di un’importante moschea di Dhaka. Quest’ultimo rimase prima incredulo, poi sinceramene deluso quando gli dissi che sì, avevo chiesto di poterlo visitare ed ero grato dell’accoglienza, ma non intendevo aderire alla sua religione. Mi raccontò allora la “parabola” di un uomo molto buono e che faceva tanta beneficienza, ma non poteva andare in Paradiso perché non era musulmano; Allah attese con pazienza e rinviò più volte la data della sua morte, fino a che l’uomo – arrivato a 150 anni di età – finalmente si convertì, e allora subito lo chiamò in Paradiso. Gli fui sinceramente grato della stima e dell’augurio, nato da una dottrina che non condividevo, ma da un cuore benevolo…
La scelta “contadina” di P. Corba fu seguita da altre, ciascuna con caratteristiche un poco diverse. P. Carlo Buzzi volle immergersi nel mondo a cui era stato inviato come missionario, vivendo per alcuni anni in un villaggio, dove lavorava con la gente, mangiando a rotazione nelle loro case; e poi – su loro richiesta – dando lezioni ai bambini e giovani. Passò poi ad un altro luogo, facendo scuola in vari villaggi circostanti e creando rapporti di stima; ci fu anche una “terza fase” in cui organizzò – in città e in parecchi villaggi – piccole scuole che raccoglievano i più poveri (ad esempio gli spazzini della città) che non avevano accesso ad altre scuole. Poi arrivò la fase “pastorale”, quando P. Carlo si dedicò a operare in parrocchia, dove tuttora continua, ovviamente arricchito dalle esperienze precedenti, che lo avevano messo in un certo senso all’interno di ambienti in cui i missionari non erano entrati, pur vivendo accanto.
Ci furono anche atti di generosità che definirei “ingenui”: la critica, più che legittima, a un possibile esagerato impegno in opere sociali ed educative, usando aiuti economici rilevanti provenienti dall’estero, risaliva già a prima del Concilio, in particolare all’insegnamento di P. Paolo Manna. Era stato il primo superiore generale del PIME, nato dall’unione di un istituto milanese e uno romano (1926). Al ritorno da una accuratissima visita, durata un anno intero, alle nostre missioni che allora si trovavano soltanto in Asia, e di contatti negli Stati Uniti anche con ambienti non cattolici, P. Manna rientrò “convertito” all’ecumenismo, ed estremamente critico dell’eccessivo uso di denaro che si faceva, a suo parere, nelle missioni, anche se l’obiettivo era ottimo. Dopo il Capitolo di cui ho fatto cenno, ci fu chi – forse cercando una soluzione facile – consegnò al governo la scuola della missione, con il triste risultato di vedere crollare la qualità e trascurate le necessità dei più deboli, che erano proprio il nostro primo obiettivo. Il problema dell’uso del denaro per chi vuole evangelizzare rimane ed è molto serio…
Comunque, nell’insieme si aprirono orizzonti nuovi positivi, che – tra l’altro – ci resero presenti in ambienti mai toccati in precedenza.
Senza voler seguire la cronologia esatta di queste iniziative, e tanto meno il loro valore, ne ricordo alcune, incominciando da una “Scuola Tecnica” intitolata a Novara per una circostanza curiosa: don Ercole Scolari, direttore delle Pontificie Opere Missionarie di Novara, conclusa una raccolta di fondi per poveri di Paesi del “Terzo Mondo”, ebbe l’idea di offrire alla FAO (Organizzazione ONU per il cibo e l’agricoltura) la grossa somma raccolta. Recatosi e Roma, si sentì dire da un funzionario che la FAO ringraziava, ma era abituata a gestire progetti molto più grandi e costosi, e non avrebbe saputo come usare una somma così modesta. Don Ercole, perplesso, poco dopo passeggiava alla stazione attendendo il treno per tornare a Novara, e proprio là, vide un anziano prete in veste bianca, piccoletto, con una barba imponente, anche lui in partenza per il nord. I due si salutarono, e don Ercole scoprì di aver incontrato il valdostano Giuseppe Obert, del PIME, vescovo di Dinajpur. Don Ercole gli confidò la sua perplessità: “Se una somma che a me sembra ingente non serve, che cosa ne faccio?” Monsignor Obert risolse subito il problema: quella somma permetteva di realizzare un suo sogno: una scuola tecnica per i tribali nel nord Bangladesh. Scuole ce n’erano già, ma la scuola tecnica voleva essere la risposta ai tempi che cambiavano, entrando in un’area nuova: preparare i giovani tribali perché non restassero ai margini, esclusi dalla modernizzazione in corso in Bangladesh: corrente elettrica, telefoni, strade asfaltate, televisione e – più avanti – una massiccia industrializzazione. Ne nacque un rapporto di amicizia e collaborazione fra la diocesi di Novara, e quella di Dinajpur: la “Novara Technical School” (falegnameria, carpenteria metallica, meccanica, elettricità, motoristica), e anche la parrocchia di cui faceva parte, con altre scuole e ostelli progredirono grazie allo stretto rapporto con Novara e a frequenti visite reciproche, che continuarono per molti anni. Migliaia di giovani trovarono lavoro, anche facilmente, perché la scuola si fece conoscere fra gli imprenditori, che anche oggi si rivolgono alla direzione per chiedere tecnici affidabili e ben preparati. Ora è passata sotto la responsabilità della diocesi e continua le sue attività diretta da un laico.
(continua)
Articoli correlati

Al Pime, le società missionarie di Europa e Africa

Schegge di storia 4 – Mondo operaio